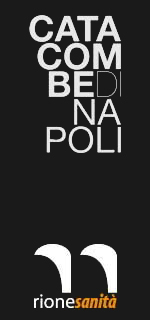Curatore: Loretta De Felice
Curatore: Loretta De Felice
Titolo: Fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate nell'Archivio Centrale dello Stato.
Sottotitolo: Tribunali militari straordinari.
Inventario.
Descrizione: In 8° (cm 17x24), pp.XX-611, legatura editoriale cartonata.
Luogo, editore, data: Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Archivi di Stato, 1998
Disponibilità: No
La legge del 15 agosto 1863 n. 1409, detta legge Pica (dal nome del proponente), dettava disposizioni «dirette alla repressione del brigantaggio». Se, come dice il Molfese « ... il brigantaggio dimostrava una vitalità che autorizzava le più nere previsioni per il 1863», l'emanazione di tale legge dovette rappresentare il mezzo per frenare il fenomeno brigantesco.
Nei primi intenti la legge doveva restare in vigore fino al 31 dicembre 1863, ma nuove leggi di modifica e proroghe ne protrassero l'applicazione al 31 dicembre 1865. L'emanazione della legge mise in moto un meccanismo che, per funzionare in modo idoneo e corretto, ebbe bisogno non solo di nuove leggi ma anche di numerose disposizioni circolari che regolassero la materia e risolvessero i quesiti insorgenti in merito all'interpretazione e quindi all'applicazione
dell'uno o dell'altro articolo di legge.
La competenza a giudicare su briganti e loro complici veniva sottratta alla giurisdizione ordinaria ed attribuita ai tribunali militari che la esercitavano nell'ambito territoriale di quelle provincie dichiarate «infestate dal brigantaggio»
con R.D. del 20 agosto 1863 n. 1414: « ... Provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore II, Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore II, Capitanata, Molise, Principato Citeriore, Principato Ulteriore e Terra di Lavoro».
D'altronde dice il Violante: «La frequente utilizzazione della giustizia militare in alternativa alla magistratura ordinaria fu determinata, in linea di massima, dalla particolare idoneità della procedura militare - caratterizzata da una scarsa incisività del diritto di difesa, dalla mancanza del grado di appello, dallo stesso habitus mentale dei giudici, scelti e perfettamente controllati dai superiori gerarchici - a garantire decisioni perfettamente allineate ai piani dell'esecutivo e non incrinate da quelle preoccupazioni garentistiche che avrebbero potuto ispirare l'attività dei giudici ordinari».