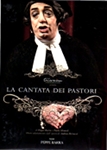 Titolo: La cantata dei pastori
Titolo: La cantata dei pastori
Autore/i: Andrea Perrucci
Registrazione effettuata presso il Teatro Trianon di Napoli, nel dicembre 2011
Regia teatrale: Peppe Barra
Musiche di Roberto De Simone, Lino Cannavacciuolo, Paolo Del Vecchio, Luca Urciuolo, Max Sacchi
Scene di Emanuele Luzzati
Direttore musicale: Luca Urciuolo
Regia video: Dario Jacobelli
Durata: 1h 56'
PAL, colore, formato 4:3
Produzione: Napoli, Marocco Music - Rocco Pasquariello
Anno di produzione: 2012
Disponibilità: No
... la produzione teatrale sacra del '600, secolo del barocco, fu copiosa e pesantemente influenzata dal rigore religioso instaurato con la controriforma; gli autori dei testi erano, di solito, "intellettuali ecclesiastici" spesso appartenenti alla Compagnia di Gesù, che usavano un linguaggio dotto e arcadico, per cui le loro opere risultavano comprensibili solo agli spettatori appartenenti alla società colta.
Il progetto politico-teatrale dei Gesuiti venne pertanto modificato, allo scopo di attrarre anche le masse popolari, con l'inclusione di maschere e personaggi comici che parlavano il linguaggio del popolo. L'inclusione di Razzullo ebbe un immediato successo. Il popolino ritornò ad affollare i teatri, spingendo, comunque, sempre di più le compagnie teatrali a dilatare il ruolo dei comici a scapito delle vicende sacre....
Altri Interpreti:
Maria Letizia Gorga - Angelo/ Zingara
Francesca Marini - Madonna/ Benino
Peppe Celentano - Armenzio
Giacinto Palmarini - Asmodeo/ Plutone
Peppe Barra - Razzullo
Patrizio Trampetti - Cacciatore/ Asmodeo
Sandro Tumolillo - Pescatore
Salvatore Esposito - Sarchiapone
Gabriele Barra - Giuseppe
Diavolo mangiafuoco - Andrea Barra
Bambina cantante - Roberta Mancuso
Le furie - Mattia Caputo, Teresa Di Guida, Andrea Casentino, Mirko Esposito, Armando Segreto, Giacomo Conte, Antonio Barra, Teresa De Rosa
L'opera narra le vicissitudini di Maria e Giuseppe nel loro viaggio verso Betlemme, le insidie dei Diavoli che vogliono impedire la nascita del Messia, la loro sconfitta ad opera degli Angeli e l'adorazione di personaggi presepiali quali pastori, cacciatori e pescatori. Vi figura, inoltre, il personaggio comico di Razzullo, uno scrivano inviato in Palestina per il censimento della popolazione, popolano affetto da fame atavica e incapace di svolgere un lavoro stabile. Per comprendere le ragioni dell'inclusione di quest'ultimo personaggio, del tutto estraneo all'impianto sacro dell'opera, occorre considerare che la produzione teatrale sacra del '600, secolo del barocco, fu copiosa e pesantemente influenzata dal rigore religioso instaurato con la controriforma; gli autori dei testi erano, di solito, "intellettuali ecclesiastici" spesso appartenenti alla Compagnia di Gesù, che usavano un linguaggio dotto e arcadico, per cui le loro opere risultavano comprensibili solo agli spettatori appartenenti alla società colta. Il progetto politico-teatrale dei Gesuiti venne pertanto modificato, allo scopo di attrarre anche le masse popolari, con l'inclusione di maschere e personaggi comici che parlavano il linguaggio del popolo.
L'inclusione di Razzullo ebbe un immediato successo. Il popolino ritornò ad affollare i teatri, spingendo, comunque, sempre di più le compagnie teatrali a dilatare il ruolo dei comici a scapito delle vicende sacre. Gli spettatori cominciarono, addirittura, ad osteggiare la rappresentazione dei personaggi sacri, anche se si commuovevano alla scena finale della Natività. Le rappresentazioni dell'opera, comunque, continuarono e verso la fine del '700 venne introdotto, a furor di popolo, un altro personaggio comico, Sarchiapone, barbiere matto, in fuga per aver commesso due omicidi. A tal punto i propositi del Perrucci risultavano del tutto stravolti. L'opera assunse il titolo di Cantata dei Pastori, continuò ad andare in scena tra lazzi e volgarità sempre più intollerabili, per cui nel 1889 intervennero le Autorità e la fecero sospendere, tanto da far dire a Benedetto Croce che l'opera era "finita", e non sarebbe stata rappresentata mai più.
Non fu così. Le rappresentazioni ripresero e le principali compagnie la inserirono nei loro programmi. Negli ultimi decenni la "Cantata" è stata più volte ripresentata con molto successo, confermando la validità del disegno teatrale del Perrucci. Le due componenti dell'opera, quella sacra e quella profana, tanto antitetiche all'inizio, si fondono, infatti, intrecciandosi nel corso della rappresentazione fino alla scena finale della adorazione del Redentore.

