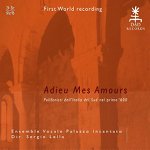 Titolo: Adieu Mes Amours - Polifonisti di Bari del Primo '600
Titolo: Adieu Mes Amours - Polifonisti di Bari del Primo '600Autore/i: Rocco Rodio, Stefano Felis, Giovanni Maria Sabino, Philippe Verdolet
Esecuzione: Ensemble Vocale e strumentale Palazzo Incantato - Dir. Sergio Lella
Libretto in 4 lingue
Produzione: DAD Records
Anno di produzione: 2005
Disponibilità: No
La centralità di Napoli, durante 3 secoli di storia della musica, è il frutto dell'opera di non napoletani. Come succede per le lettere e le arti in generale, anche la musica dei secoli XVI-XVIII ha per protagonisti uomini arrivati a Napoli attratti dalla sua forza politica; spesso questi uomini provengono dalle province del Regno.
Basilicata e Calabria, ma sopratutto Puglia, sono la fonte della ricchezza materiale della capitale: molti feudatari delle province hanno palazzi e interessi sociali a Napoli, e qui inevitabilmente confluiscono beni e risorse umane.
Nelle vicende dinastiche che alternano spagnoli e francesi, Napoli conserva comunque il primato nel Regno: anche quando è Capitale senza Re. Bari all'inverso resta nel ruolo di città di provincia anche quando conquista una relativa autonomia politica. Eppure questa circostanza, questa provincialità non dice tutto. Perché, attraverso la migrazione verso Napoli, alcuni musicisti di Bari diventano musicisti d'Europa.
Per quasi un secolo, dal 1464 al 1557, da quando cioé gli aragonesi cedono la città agli Sforza, e in modo particolare durante tutto il regno della cosiddetta Regina di Bari, Bona Sforza, questa relativa autonomia corrisponde ad un periodo fertile di attività culturale, la cui misura è data dalla notevole circolazione in città di musicisti provenienti da altre corti italiane.
Subito dopo inizia il flusso a senso unico verso Napoli, e così sarà sempre nei decenni e secoli futuri, con una regolarità che caratterizza la vita musicale della città di Bari: ci sarà un'attività musicale, nelle cappelle principali, ma essa non sarà parte della circolazione nella penisola e nel resto d'Europa.
In un periodo immediatamente successivo al regno di Bona Sforza accade nella storia della musica un fatto di enorme importanza che modifica per sempre la circolazione di musiche e autori: l'affermazione della stampa musicale come industria fiorente. All'interno di questo fenomeno e con questa nuova unità di misura occorre valutare l'affermazione delle nuove generazioni di musicisti.
A partire dagli anni '80 del secolo XVI, quanto un compositore sia affermato nel panorama italiano ed europeo si misura con il successo editoriale.
Certo gli incarichi presso Cappelle e Corti, le professioni musicali tipicamente rinascimentali, sono sempre ambiti e decisivi per il successo professionale; ma l'autore di musica è tale anche e soprattutto attraverso i suoi libri di musica a stampa, la loro circolazione, il numero delle ristampe nei decenni, la frequenza con la quale i grandi stampatori europei riprendono nelle loro antologie le composizioni di questo o quell'altro autore.
Sicuramente in ambito sacro la musica è stampata con meno frequenza, perché è in primo luogo musica d'uso delle Cappelle. Ma proprio per queste ragioni il numero di opere sacre di un autore che finiscano in stampa segnano ancor più una notorietà acquisita.
E' altrettanto certo, per ciò che riguarda la musica profana, e i vari generi madrigalistici in particolare, che le vicende editoriali costituiscono il più attendibile terreno di valutazione del successo.
Forse oggi, abituati come siamo a considerare la nostra era come quella massimamente capace di comunicazione, facciamo fatica a comprendere la vastità di un fenomeno di oltre quattro secoli fa, dal punto di vista industriale e dal punto di vista culturale: frenetica produzione di libri di musica, capillare diffusione in tutto il continente, eccezionale velocità di diffusione dei nuovi prodotti. Il primato indiscusso, in Italia, di questa attività è di Venezia, ma con un ruolo crescente di Napoli.
Alcuni compositori nativi di Bari sono tra i protagonisti di questa circolazione; la loro produzione si snoda nell'arco di circa 70 anni, dal Missarum Decem di Rodio (1562) fino alle ultime pubblicazioni importanti di G.M. Sabino, stampate alla fine degli anni '20 del secolo XVII
Rocco Rodio è il più antico, tanto da aver vissuto la stagione di Bona Sforza; il matrimonio di questa con Sigismondo di Polonia fa ipotizzare un suo contatto con quella corte: la spiegazione più semplice della presenza di sue composizioni a stampa in biblioteche polacche. Tra i libri superstiti spicca la collezione delle dieci messe dedicate al figlio di Bona e Sigismondo e un trattato di teoria del contrappunto più volte ristampato nei decenni successivi e molto citato da altri teorici, anche per le forti dichiarazioni in esso contenute circa il rapporto tra regola accademica ed effetto musica/e.l Rodio è anche il più longevo ed attraversa nei suoi circa ottanta anni di vita i mutamenti in atto: ci restano poche e frammentarie notizie, che pure sono sufficienti per immaginarlo impegnato direttamente nelle sperimentazioni dei nuovi stili.
Di una generazione successiva, almeno dal punto di vista anagrafico, sono Stefano Felis, Muzio Effrem e Pomponio Nenna: tutti legati, ma in modi molto diversi, alla figura di Carlo Gesualdo, loro coetaneo. E qui occorre chiedersi se e come il legame col principe-musicista abbia influito sulle vicende editoriali di quei musicisti; sicuramente i componenti del cosidetto Circolo di Gesualdo ebbero non pochi problemi con un'attività che era per eccellenza 'professionistica' e quindi preclusa al Principe per obblighi di casta; è noto anche come ogni stampa di madrigali di Gesualdo avesse bisogno della copertura di qualcuno che la promuovesse dichiarando una vera o presunta estraneità del Principe all'impegno editoriale.
Insomma gli amici del Principe non hanno tratto vantaggi professionali da quella appartenenza. E forse neanche una fama postuma. Lasciando da parte il caso di Nenna , sono emblematici i casi opposti di Muzio Effrem e di Stefano Felis.
Muzio Effrem, anch'egli nobile, è il più legato a Gesualdo, al quale resta vicino addirittura per un ventennio diventando il suo fedele custode spirituale, curando una importante stampa postuma di musiche sue e anche ingaggiando una dura polemica con Marco da Gagliano, accusato pubblicamente di presunti plagi ai danni del Principe5.
Effrem gode anche di autorevolezza e fama, provate dalle sue affermazioni a Mantova, dove appare addirittura accanto a Monteverdi tra gli autori di musiche per rappresentazioni sacre. Eppure non pubblica quasi nulla: poche cose riprese in antologie ed un madrigale usato come esempio nella famosa polemica. Anche le vicende legate ai suoi incarichi professionali a Napoli sembrano come sospese: cercò ed ottenne un impiego nella cappella reale, ma lo abbandonò, probabilmente per restare accanto a Gesualdo. Questo legame, più che l'obbligo nobiliare, è la ragione per cui la musica di Effrem fu stampata così poco, e di conseguenza la ragione per la quale ne è giunto a noi quasi nulla.
AI contrario Stefano Felis, i cui rapporti con Carlo Gesualdo furono molto più labili, spicca per frequenza e continuità editoriale: nel campo del madrigale non meno di 10 libri di musica stampati nell'arco di vent'anni, tra il 1583 e il 1602, e in campo sacro quasi altrettanti libri, di Messe e Mottetti.
Parte della produzione profana di Felis, già di per sé molto significativa, fu ripresa in varie ristampe; ma ciò che è più significativo è la presenza di molti suoi madrigali nelle antologie curate da alcuni dei massimi stampatori del nord Europa. Di sicuro giovò a Stefano Felis l'aver svolto una carriera più normale, con l'incarico di maestro di cappella prima a Bari e poi a Napoli, e sicuramente anche l'aver viaggiato al seguito del suo primo datore di lavoro, il cardinale Puteo. Felis fu anche al centro di una fitta rete di relazioni editoriali con compositori della sua stessa città, ospitando nei propri libri opere di almeno sei dei propri allievi e colleghi.
A questi compositori seguì un' altra generazione, alla quale appartiene Giovanni Maria Sabino, il più anziano di una stirpe di musicisti pugliesi ormai residenti stabilmente nella capitale. A partire dal 1600 i musicisti attivi a Bari scompaiono dalla scena italiana. Con Sabino, infatti, siamo in un altro mondo musicale e anche in un altro mondo professionale.
Elenco dei brani:
1. Adieu mes amours : Madrigale (Josquin del Près) - 4:02
Rocco Rodio, Missa Adieu Mes Amours
2. Missa adieu mes amours : Kyrie - 3:29
3. Missa adieu mes amours : Gloria - 4:16
4. Omnes gentes, per le viole (Giovanni Maria Sabino) - 1:57
5. Missa adieu mes amours : Credo - 6:55
6. Missa adieu mes amours : Sanctus - 2:14
7. Jubilate deo, per le viole (Giovanni Maria Sabino) - 1:56
8. Missa adieu mes amours : Agnus dei - 2:03
9. Fantasia a 4 sopra la Spagna (Rocco Rodio) - 2:44
10. Ultimi miei sospiri : Madrigale a 6 (Philippe Verdelot) - 2:29
11. Exultate deo, mottetto a 8 (Stefano Felis) - 2:36
12. Cantate domino, mottetto a 8 (Stefano Felis) - 3:50
13. Viri sancti, mottetto a 2 (Giovanni Maria Sabino) - 2:43
14. Laudate pueri, mottetto a 3 (Giovanni Maria Sabino) - 4:06
15. Ecce panis angelorum, mottetto a 4 (Giovanni Maria Sabino) - 5:08

